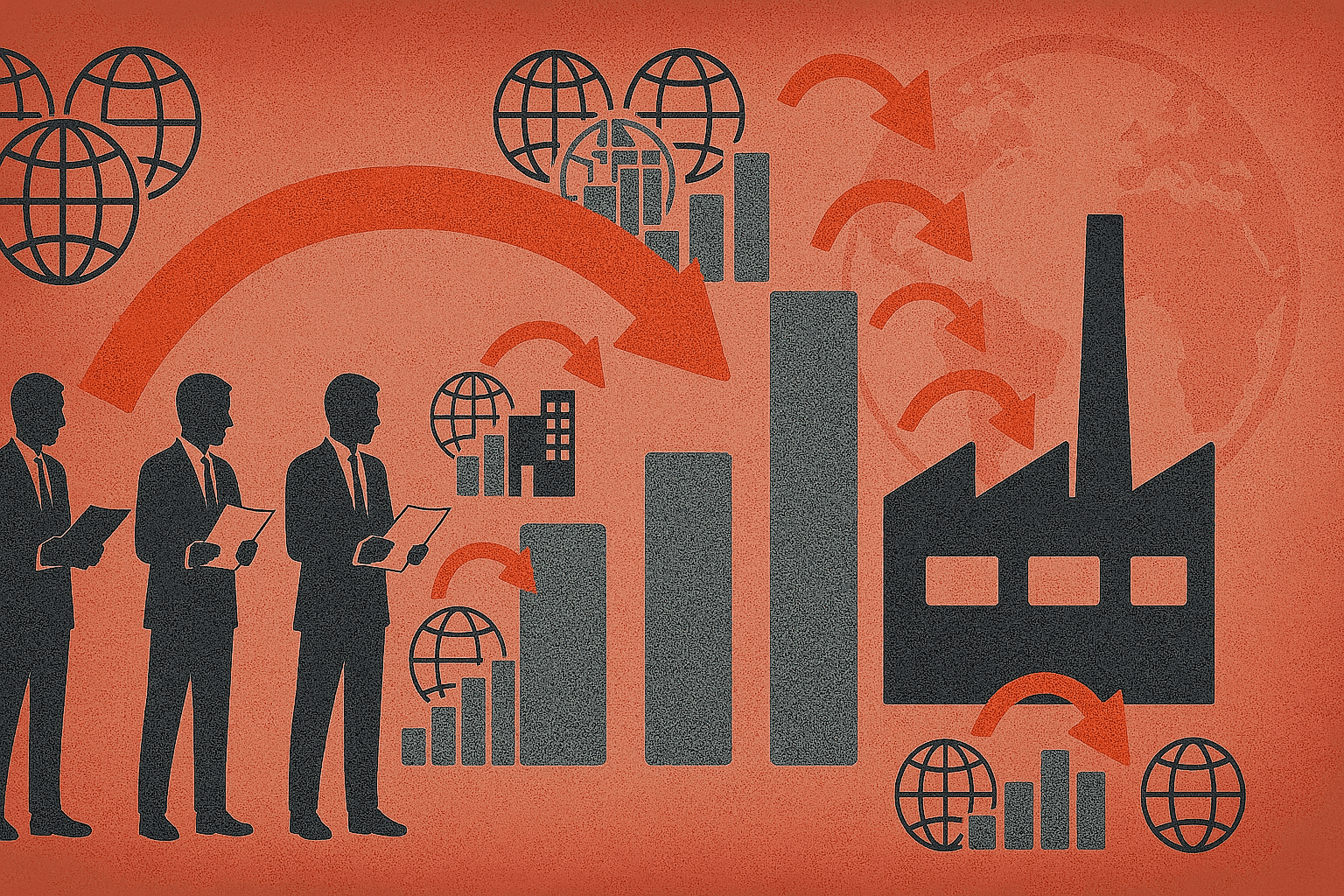Negli ultimi anni si è aperto un profondo divario tra il modello di sviluppo della Cina e quello dei paesi occidentali.
Mentre Pechino sta riportando sotto il controllo statale i gruppi industriali considerati strategici — dalle terre rare ai semiconduttori, dall’energia ai trasporti — l’Occidente continua ad affidare la propria struttura produttiva ai grandi conglomerati privati, limitandosi a intervenire con strumenti di mercato come dazi, incentivi fiscali e politiche di reshoring.
A prima vista, entrambe le strategie sembrano mirare a proteggere la sovranità economica. Ma in realtà, il risultato è molto diverso.
La Cina ha scelto la via del controllo diretto, ricentralizzando la proprietà e la governance dei grandi gruppi. Gli Stati Uniti e l’Europa, invece, hanno mantenuto un sistema decentrato e privatizzato, nel quale le multinazionali continuano a riorganizzarsi in base a proprie logiche di profitto globale.
Le multinazionali come centri autonomi di potere
Nel modello occidentale, i grandi gruppi privati non sono più semplici attori economici: sono diventati centri autonomi di riorganizzazione della produzione e della finanza globale.
Le loro decisioni di investimento, di delocalizzazione o di ridefinizione dei prezzi interni possono modificare interi equilibri settoriali, spostando capitali e occupazione da un continente all’altro nel giro di pochi mesi.
Tutto ciò avviene senza un coordinamento pubblico e spesso in risposta a incentivi temporanei, pressioni speculative o mutamenti nei tassi di interesse.
In questo contesto, anche un modesto cambiamento nella strategia di un grande gruppo può produrre effetti a catena sull’economia reale, sui mercati finanziari e persino sulle politiche monetarie.
Le crisi “indotte” dalle riorganizzazioni private
Si parla così di crisi indotte: turbolenze economiche non originate da shock esterni (come guerre o pandemie), ma dalle stesse dinamiche interne del sistema produttivo privato.
Quando una multinazionale modifica la propria struttura, riduce la produzione in un paese o sposta la catena di fornitura, l’impatto non resta circoscritto al suo bilancio: si propaga lungo le filiere, riduce la domanda aggregata e altera i flussi finanziari internazionali.
A differenza della Cina — dove lo Stato può guidare questi processi — l’Occidente può solo reagire ex post, con interventi di emergenza che spesso non eliminano la causa strutturale della crisi: la totale libertà di riorganizzazione dei grandi gruppi privati.
Una vulnerabilità sistemica
Questa condizione rappresenta oggi uno dei più gravi rischi sistemici per le economie occidentali.
L’apparente libertà del mercato globale si traduce in una dipendenza reale da pochi soggetti che concentrano al proprio interno funzioni produttive, finanziarie e decisionali.
Si tratta di una forma di “sovranità privata” che sfugge al controllo democratico e rende le politiche economiche sempre più reattive e sempre meno preventive.
Quando un gruppo decide di riallocare capitali o di modificare la propria catena di approvvigionamento, l’intero sistema produttivo nazionale può trovarsi in difficoltà.
E poiché queste decisioni sono prese in funzione del profitto immediato, non della stabilità collettiva, le crisi diventano endogene, cioè generate dal cuore stesso dell’economia globale.
Verso una nuova teoria della stabilità
Per comprendere e anticipare queste dinamiche occorre ripensare le categorie tradizionali di “mercato” e “concorrenza”.
Come evidenzia la teoria dell’“economia apparente a contraente unico”, le società formalmente autonome che compongono un gruppo multinazionale non agiscono come entità indipendenti, ma come parti di un unico organismo economico che fissa da sé i propri prezzi, le proprie forniture e i propri flussi finanziari interni.
In questa prospettiva, la vera sfida dell’Occidente non è tanto competere con il modello statale cinese, quanto ricostruire meccanismi di regolazione e monitoraggio capaci di limitare il potere destabilizzante delle grandi strutture private e di prevenire le crisi sistemiche che esse stesse possono generare.